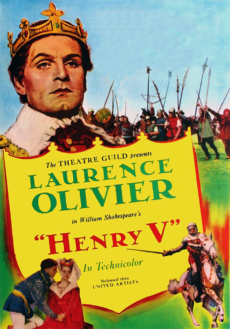Un film di Kevin Costner. Con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd Red Crow Westerman. Titolo originale Dances with Wolves. Western, Ratings: Kids+13, durata 180 min. – USA 1990. MYMONETRO Balla coi lupi 



 valutazione media: 4,40 su 50 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
valutazione media: 4,40 su 50 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
C’era stato un tempo in cui il western era uno dei generi più popolari di Hollywood. Che si trattasse di Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco o Burt Lancaster e Kirk Douglas in Sfida all’OK Corral o Clint Eastwood nella trilogia di Sergio Leone, il vecchio West era un modo sicuro per stare in testa al box office fino agli anni ’70 quando scomparve repentinamente quasi del tutto. Ma Kevin Costner nel 1990 riaprì al meglio la stagione del western e nel giro di tre anni ben due film del genere (per l’appunto Balla coi lupi e “Gli spietati”) riuscirono ad aggiudicarsi l’ambita statuetta di miglior film agli Oscar. E per la prima volta Hollywood “premiò gli Indiani” (e lo fece nella persona di Costner, un diretto discendente della tribù Cherokee) anche se non era certo il primo western della parte dei nativi americani. La pellicola si guadagna un indiscusso posto d’onore nella storia del cinema, non sfigurando di fronte ad un inevitabile confronto con i maestri di sempre. Ed è certo il solo film di questi ultimi vent’anni ad affrontare il mito del West, oggetto di tanto revisionismo annunciato, con una passione e un realismo che vanno in direzione della leggenda anziché della demistificazione. Diretto e coprodotto oltre che interpretato dallo stesso Kevin Costner è un debutto impressionante. Ne sono state più volte sottolineate le debolezze che sfiorano il manicheismo e il culto dello spettacolo, non considerando invece come riesca a coniugare i canoni propri del genere a vantaggio di una narrazione epica che conferisce un raro stato di grazia e di sentito a questo racconto elegiaco interessato più che alla fedeltà storica a una verità morale e antropologica. Ma gli intenti di Costner non rifuggono spesso dall’utopia. Balla coi lupi ha la forza e i difetti della sua semplicità e della sua programmatica generosità, conservando una qualità indiscutibilmente emozionante: quella di contribuire a trasmettere l’invito a conoscere l’altro prima di decidere di combatterlo o sterminarlo.



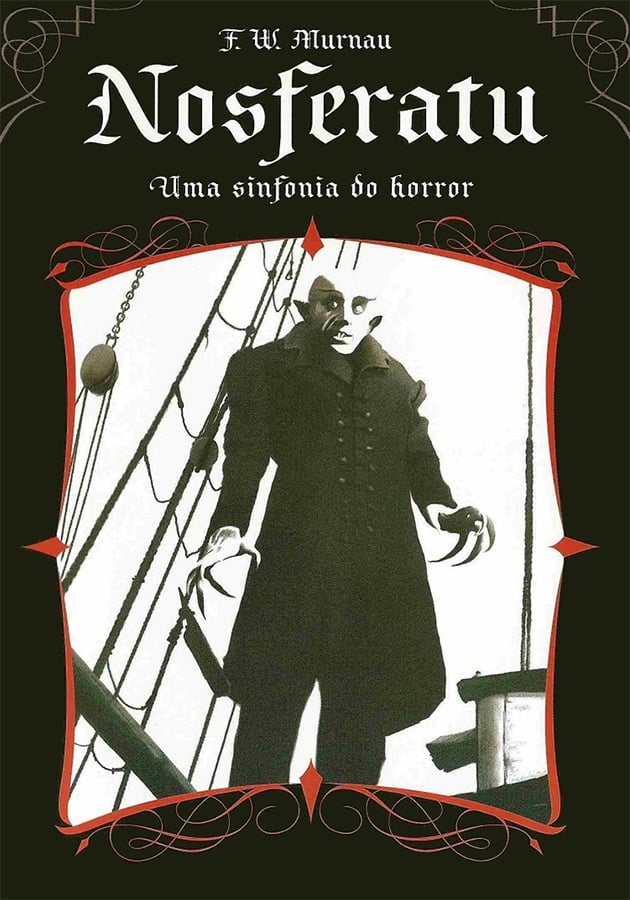




 valutazione media: 4,48 su 14 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
valutazione media: 4,48 su 14 recensioni di critica, pubblico e dizionari.













![Locandina Orizzonte perduto [1]](https://pad.mymovies.it/filmclub/2006/03/029/imm.jpg)