
Regia di Robert Clouse. Un film con Dean Jagger, Gig Young, Bruce Lee, Kareem Abdul-Jabbar, Colleen Camp. Titolo originale: The Game of Death. Genere Drammatico – Hong Kong, USA, 1978, durata 102 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: V.M. 14 – MYmonetro 2,17 su 1 recensioni tra critica, pubblico e dizionari.
Billy Lo, esperto di arti marziali, è un’affermata action-star di Hong Kong all’apice della carriera. Quando il giovane attore rifiuterà l’offerta di una potente organizzazione che vorrebbe ‘curare i suoi interessi’, la sua vita diventerà un inferno: dopo inutili minacce e intimidazioni, sarà vittima di un grave attentato. Inscenerà così la propria morte per potersi poi vendicare, ed in un sanguinoso finale scalerà la ‘torre’ dell’organizzazione affrontando nemici sempre più pericolosi. A cinque anni da I Tre dell’Operazione Drago, nonchè dalla morte di Bruce Lee, la Golden Harvest decide di montare un’impalcatura improbabile sopra venti minuti scarsi di materiale inedito girato da Lee anni prima. Peccato che per arrivare a vedere gli epici combattimenti contro Danny Inosanto e Kareem Abdul-Jabbar, ideale trasposizione filosofico-marziale della dottrina dell’adattamento tanto predicata da Bruce Lee, ci si debba sorbire più di un’ora di pena assoluta. Le scene aggiunte sono infatti improponibili sotto ogni punto di vista. I due ‘imitatori’ ingaggiati per sostituire il vero protagonista danno all’intera pellicola il tono di una mascherata, portando costantemente giganteschi occhiali scuri e tentando goffamente di riproporre le singolari movenze di Lee, con esito ridicolo. Tutti i primi piani sono saccheggiati da precedenti film e, come se non bastasse, per il funerale sono state usate alcune immagini del vero funerale di Bruce Lee, feretro compreso, in un orripilante quanto ‘calcolato’ tentativo di omaggio. Sforzandosi di ignorare simili bassezze, rimane un agglomerato di sequenze buone solo per fare metraggio. Oggi i gloriosi combattimenti del finale si possono reperire sul documentario Bruce Lee – La Leggenda (2000), quindi nessuna pietà per questo scempio.



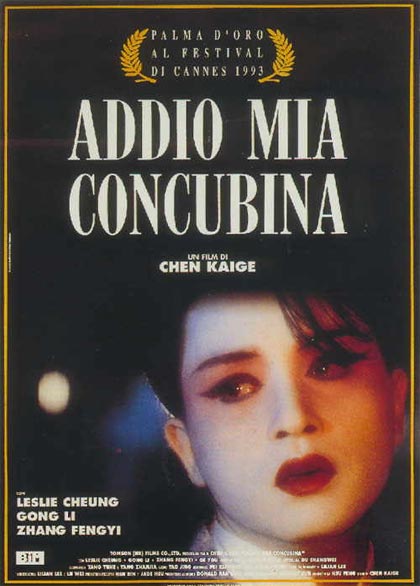




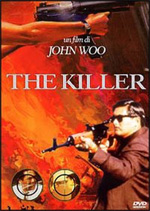


 valutazione media: 3,51 su 17 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
valutazione media: 3,51 su 17 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

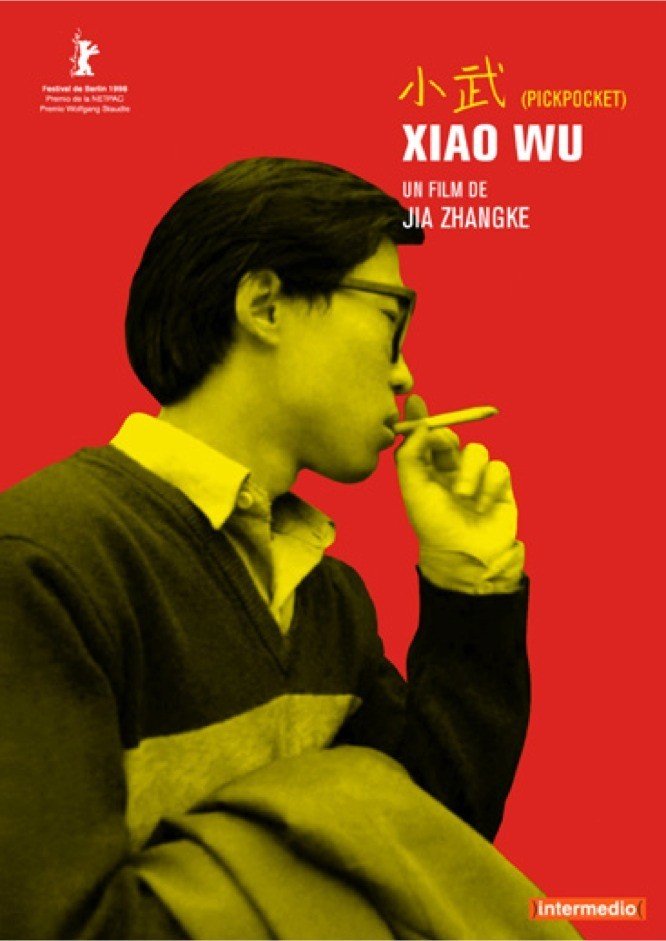


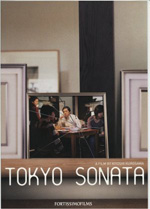
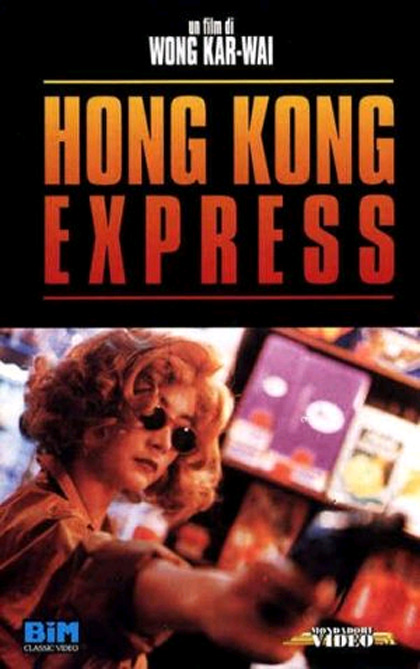






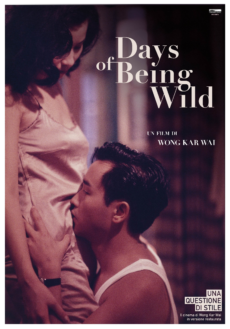


 Overheard 2 è un film di
Overheard 2 è un film di 





 Un film di
Un film di